 Era maestro di retorica alla corte imperiale, era uomo di studi profondi e di amicizie intense, aveva una donna che amava. Agostino prima della conversione era, ha detto il Papa in apertura del Capitolo dell’ordine agostiniano, «un uomo arrivato».
Era maestro di retorica alla corte imperiale, era uomo di studi profondi e di amicizie intense, aveva una donna che amava. Agostino prima della conversione era, ha detto il Papa in apertura del Capitolo dell’ordine agostiniano, «un uomo arrivato».Eppure, interiormente insoddisfatto, cercava; per vie anche sbagliate, da peccatore, continuava a cercare il volto di Dio. È così attuale la vicenda umana di Agostino, che sembra storia di oggi. ( Tendiamo sempre a pensare che i santi nascano già santi, dentro a un’aura immateriale e pura. Invece Francesco ha raccontato di un uomo, che un tempo non era così profondamente diverso da noi). Che cosa ne suscitò il cambiamento? Dapprima una insoddisfazione, una tenace inquietudine; come se tutto ciò che quell’uomo aveva non gli potesse bastare. Poi, anche quando trova Dio, Agostino non si chiude in se stesso come fosse arrivato; invece è spinto dall’urgenza di annunciare agli altri il Dio che ha incontrato. «Sempre in cammino, sempre inquieto», ha detto Francesco: questa, ha aggiunto, «è la pace dell’inquietudine».
La pace dell’inquietudine. In questo mese in molti abbiamo riposato, credendo di poter finalmente trovare in giornate tranquille la pace che ci sfugge, crediamo, per troppi impegni. Ma qualcuno di noi ha sperimentato, proprio nel sospirato momento in cui si può stare tranquilli, l’insorgere di una sottile inquietudine. Come se qualcosa, anche nella bellezza del mare o delle montagne, mancasse; come se la pace non si presentasse in quel riposo, e anzi la sua mancanza, nella quiete e nel silenzio, si facesse più vistosa. Insomma, abbiamo sperimentato l’inquietudine nella pace; e oggi invece il Papa ci dice di una pace dell’inquietudine.
Sembra, questa pace agostiniana di cui parla Francesco – in un forte eco di Benedetto XVI, da sempre innamorato di Agostino – qualcosa di totalmente diverso dalla pace come la intendiamo noi, quando andiamo in vacanza e ci ripromettiamo: adesso, non ci sono per nessuno. La nostra pace immaginaria è un chiudersi; è un atollo di cui difendiamo gelosamente i confini. La pace di cui ha parlato il Papa invece è un essere in cammino: giacché non può smettere di andare, chi cerca il volto di Dio. Né può ignorare i compagni di strada che gli si affiancano; perché anzi avverte l’ansia di dire, a quegli sconosciuti, del Dio che ha incontrato.
Ci ha chiesto, il Papa, se siamo fra gli inquieti, o fra quelli che «si sono accomodati» nella vita cristiana: paghi di ciò che hanno. Una domanda su cui varrebbe la pena ci soffermassimo, se siamo tra quanti hanno sperimentato, nella pace dell’estate, una confusa inquietudine. Come se qualcosa, anche quando all’apparenza non manca niente, cocciutamente mancasse. Come se fossimo fatti per qualcosa di più grande di ciò che stringiamo fra le mani. «Qualunque cosa tu dica o faccia c’è un grido dentro: non è per questo, non è per questo!», dice una poesia di Clemente Rebora; come la riarsa preghiera di un uomo che soppesi ogni cosa, e scuota la testa: no, nemmeno questo è abbastanza.
Ma l’inquietudine nel tempo della pace può essere la spia di una domanda vera. «Ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te», scrisse Agostino. Forse dovremmo prendere sul serio questa ipotesi, questo desiderio, di tutti il più censurato, come ci esorta il Papa. Con toni interamente suoi eppure in fedele continuità con Benedetto, che nel “Gesù di Nazaret” diceva che occorre essere come il vir desideriorum del libro di Daniele, che «non si accontenta della realtà esistente e non soffoca l’inquietudine del cuore, quell’inquietudine che rimanda l’uomo a qualcosa di più grande». Rimettersi in cammino, dunque, verso il più profondo dei desideri del cuore. Nella fatica della strada, nella attenzione al compagno, in questa tesa domanda, ci dice Francesco, è la pace. Non quella che ci illudiamo di fabbricarci da noi come un castello illusorio, ma la pace vera. MARINA CORRADI








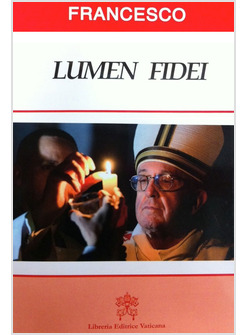
 VENT’ANNI FA VENIVA PUBBLICATA L’ENCICLICA «VERITATIS SPLENDOR»
VENT’ANNI FA VENIVA PUBBLICATA L’ENCICLICA «VERITATIS SPLENDOR»




