
Testi di riferimento: J. Carrón, «Introduzione», in «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?», suppl.
Tracce-Litterae communionis, n. 5, maggio 2013, pp. 4-12; J. Carrón, «Ubi fides, ibi libertas»,
Tracce-Litterae communionis, n. 4, aprile 2013; J. Carrón, «Anche in politica l’altro è un bene», la
Repubblica, 10 aprile 2013, p. 29.
• L’iniziativa
• Romaria
Gloria
Riprendiamo di nuovo la Scuola di comunità con il lavoro che ci siamo dati: l’Introduzione agli
Esercizi della Fraternità, il testo «Ubi fides, ibi libertas» nel Tracce di aprile, e la lettera che ho
scritto a la Repubblica il 10 aprile scorso. Sono tutti strumenti che hanno come scopo approfondire
quel che ci siamo detti a Rimini.
Del venerdì sera agli Esercizi c’è una cosa che mi ha colpito immediatamente, ed
è stata la prima affermazione che hai fatto: non basta il nostro fare per ridestare
la nostra umanità. Questa questione mi ha provocato molto perché, se da un lato
sono sicuro che questa affermazione io non la nego, d’altro canto, nella vita
quotidiana, accade spesso il contrario, accade spesso che prevalga l’organizzare,
il fare, il voler comunque sistemare la questione e la giornata, nel tentativo
illusorio che questo serva alla mia umanità, che ridesti la mia umanità. E scopro
che il Signore utilizza le circostanze più strane, anche più ordinarie, per
correggermi.
Mi è successa questa cosa: arrivo una mattina in ufficio, e mi avvisano che c’è un
cliente che chiede di parlarmi, un cliente che non aspettavo assolutamente; vado
a riceverlo a malincuore (perché comunque avevo già programmato cosa fare
quella mattina). È una persona che conosco da tempo, bravissimo, buono,
stimatissimo, che nell’ultimo anno è stato toccato drammaticamente dalla vita.
E mi chiede un parere che riguarda questioni di soldi. Io gli faccio un po’ di
domande per inquadrare la questione,e a un certo punto lui mi dice: «Guardi, io
so che quei soldi non mi spettano, però se appena appena ho la possibilità, per
qualche cavillo, di potermi rifare io lo voglio fare perché mi hanno trattato male».
Allora ho iniziato a dargli un parere. E sul finire di questo incontro, mentre lo
stavo salutando – io potevo chiudere la questione così, svogliatamente, perché
era comunque un imprevisto che mi stava facendo perder tempo quella mattina –,
è emersa in modo impressionante in me la necessità di non lasciar perdere il
nocciolo di quel che lui mi stava raccontando. E gli ho domandato: «Scusi, ma è
possibile che lei voglia rispondere a un torto subito con un altro torto? È
possibile vivere così, da questo punto di vista?». La questione è finita lì, così.
Mi ha colpito per il fatto che capisco che in me – in noi – c’è un qualcosa di
irriducibile, che io posso tentare di censurare e di nascondere, ma che
nell’impatto con la provocazione della realtà emerge, a un certo punto emerge.
Ed è la stessa questione, mi pare, che tu dicevi nella lettera a la Repubblica, che
mi aveva colpito perché, al contrario di tanti commenti che avevo letto e sentito
sulla situazione italiana – cito quelli più benevoli, dove si diceva: «Dobbiamo
rimetterci insieme, dobbiamo dimenticare gli odi per fare qualcosa per l’Italia» ,
tu non ti limitavi a questo, ma sei andato al fondo dell’origine che permette
questa convivenza, questa possibilità di stare insieme. E questa per me è una
posizione che scaturisce dalla fede, cioè da un uomo che viene investito
dall’avvenimento di Cristo e che è capace di guardare così a fondo la realtà
e di giudicare così la realtà.
Ma perché, secondo te, questo c’entra con la fede?
Secondo me c’entra con la fede perché solo una posizione di fede così ha la
capacità di risvegliare l’umano che è in me.
2
Cioè: ciò che risveglia l’umano, come abbiamo sempre detto a partire dal
capitolo decimo de Il senso religioso, è la realtà. Tu hai descritto dei
fatti reali. Punto. Questi sono ciò che ridesta. La questione è che quanto
più io vivo la fede tanto più questa mia umanità emerge proprio perché
ridestata nell’incontro con la Presenza eccezionale, proprio perché la
convivenza con Gesù, come abbiamo detto in «Ubi fides, ibi libertas»,
ci rende sempre più in grado di sperimentare che le cose ci parlano.
Infatti a te ha stupito il fatto che tu avresti potuto non fare caso a quel
che ti accadeva quella mattina, durante quella visita inaspettata, come
io avrei potuto non rendermi conto dell’origine del caos politico.
C’entra con la fede perché, vivendo alla presenza di Cristo, vivendo in
un luogo dove Cristo accade, il Mistero ci educa a essere sempre più
disponibili, quindi a lasciarci toccare da tutto; non perché siano diverse
le cose (un altro impatta la medesima realtà che impatto io), ma perché
è diversa la capacità di stupore di un io afferrato da Cristo. Per questo
come ci siamo detti qualche anno fa – la fede non appiattisce l’umano;
al contrario, quel che fa la fede è esaltare l’umano, infatti il senso
religioso è la verifica della fede, e in questo senso c’entra con la fede:
essere sempre più stupito che la realtà mi parla (non che sia io in
grado di fare qualcosa), per cui – come tu hai detto molto bene la
costruzione della mia vita non comincia dal mio fare, ma comincia
da questo lasciarmi costantemente colpire da una Presenza che mi
ridesta costantemente, tanto che tutto diventa segno, qualsiasi
circostanza. Questo è il desiderio che abbiamo: che possiamo vivere
tutto così! Perché l’alternativa è essere piatti davanti a qualsiasi cosa
che accade.
O molto arrabbiati.
Come sappiamo bene… Grazie.
Io sono rimasto colpito e ricolpito quando ho ripreso l’Introduzione agli Esercizi,
ma già quellasera a Rimini lo ero stato in modo fisico, quasi, quando tu hai
concluso citando l’Apocalisse: «Sei costante e hai molto sopportato per il
mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il
tuo amore di prima».
E tu hai sottolineato: «Il nostro primo amore dov’è?». È stata come una
stilettata al cuore, da una parte, liberandomi (perché era come se toccassi
finalmente quel che mi interessa davvero) e, dall’altra, riaprendo la ferita.
Il mio primo amore è l’unica cosa che mi interessa, e rimetterlo a tema è ciò
che mi fa vivere, che mi rimette in moto. Ti racconto due fatti. Alla fine di
aprile è caduto l’anniversario della mia ordinazione, si è fatta una festa (anche
ben riuscita, direi) e c’era un po’di gente di varia provenienza, tra di loro molti
forse nemmeno si conoscevano. C’era da mangiare la porchetta, e poi
abbiamo fatto qualche canto. Il primo canto è stato dedicato a me; appena
è cominciato io sarei scappato, me ne sarei andato, non per imbarazzo, ma
perché c’era qualcosa che non andava. E subito ho pensato: beh, sarà per il
mio solito carattere da piemontese… E invece ho capito che il problema era
che guardare quella festa centrandola sul mio anniversario era spostarsi dal
primo amore, fino a rimanere senza fiato.
Perché? Perché al centro della festa, in realtà, era evidentissimo che c’era una
storia di amicizia che aveva fatto Lui, aveva intrecciato Lui, e Lui era la
ragione per cui valeva la pena fare la festa. Perché per me era chiarissimo che
Lui ha una fisionomia che, messa al centro, riempie i cuori, mentre appena
sposti lo sguardo tutto diventa pesante. Il secondo episodio riguarda un
incontro in cui tu eri intervenuto, rispetto a una difficoltà che avevamo trovato
e anche a una discussione cheera stata abbastanza dura, a dirimere un po’ la
situazione aiutandoci a fare un passo avanti. E mentre tu parlavi, mi
accorgevo che io avrei ribattuto, avrei detto: «Non è esattamente così»,
avrei messo i puntini sulle “i”. Ma lì, di nuovo, è come se fosse venuto fuori
benissimo che io dovevo scegliere se lasciarmi affascinare dalla Sua presenza
che tu descrivevi, facevi venir fuori, rimettevi al centro, e che creava un’unità
e che era bella da vedere, oppure se mettere i puntini sulle “i” e rimanere su
altro. Mi ha colpito perché è proprio quel che dice il Papa, cioè che l’unica
cosa che fa vivere è andare dietro a Lui così come si fa vedere, affascinante
com’è, altrimenti si rimane su delle strutture (per carità: del movimento,
cristiane, che parlano di Lui) che non fanno vivere.
In che cosa si vede il mio primo amore dov’è e cosa è successo del primo
amore? Che uno si trova davanti a una festa e si sorprende che è
bellissima, che è organizzata con tutta la buona intenzione; ma che
Lui non è al centro. È come se cominciasse a diventare nostro quel
che ci testimoniava don
3
Giussani nell’episodio di quella festa, che abbiamo citato a pagina 23
del libretto degli Esercizi. E questo dice del cammino che stiamo facendo
e aiuta a rispondere alle domande che a volte ci facciamo. Scrive una
persona: «Da qualche mese il mio fidanzato è all’estero. Già dopo poco
tempo che era là è rimasto colpito dal fatto che, nonostante fosse una
città prevalentemente atea, o al massimo protestante, ci sono delle
famiglie bellissime, coppie giovani che si sposano, tanti figli,lavorano
un sacco in modo da poter tornare a casa verso le quattro del
pomeriggio e dedicarsi alla famiglia. “Bellissimo!”, mi diceva. Ma
allo stesso tempo, immediatamente, la sua domanda: “Ma se questi
che sono atei hanno delle famiglie belle, così belle, che cosa aggiunge,
qual è il di-più del cristianesimo?”. Sinceramente all’inizio mi sembrava
una domanda non inutile, ma dalla risposta ovvia. Ero anche un po’
sconfortata dal fatto che lui fosse curioso e così attratto dalla possibilità
che un mondo senza Cristo fosse possibile e bello. Poi gli Esercizi sono
cominciati con quella stessa domanda che ho dovuto, a quel punto,
prendere per forza in più seria considerazione. La settimana dopo sono
andata a trovarlo e ho potuto vedere e toccare con mano che è il luogo
perfetto dove è inutile essere buoni [la famosa immagine di Eliot], dove
si può fare tutto, basta che si rispettino le regole, dove viene insegnata
la possibilità delle cose. Ma non la loro verità. E quando sono tornata a
casa la domanda degli Esercizi era ancora più viva: “Che differenza
c’è tra l’essere delle brave persone e un cristianesimo in carne e
ossa?”». È questa domanda che urge sempre di più. Perché?
Perché tante persone sono brave, vivono così (uno può andare alla festa
e accontentarsi di questo). Lo dice bene Giussani in L’attrattiva
Gesù (a pagina 165) rispondendo a una persona che era tornata
dall’Africa: «Se laggiù eri qualche cosa di ben di più, era perché avevi
questo [la fede]: sta’attenta a non perderlo qui. È più facile perderlo
qui [lo diceva in una casa dei Memores Domini, che sembrerebbe il
luogo più adeguato per poter vivere la fede] che in Africa, è più facile
perderlo in casa tua che neanche in Africa. […] Perché casa tua,
creata per l’influsso di Cristo, è così piena di umanità, piena di colori
e di sapori e di figure, è così diversa dalla vita solita, che ti appaga.
Perciò,appagata dalla compagnia, dimentichi la radice della compagnia».
Cioè: possiamo creare un mondo pieno di umanità, che ha la sua origine
nella presenza di Cristo, e non sentire più il bisogno di dire il Suo nome,
e non sentire più l’urgenza di quella sterminata tensione, di quella
esasperata tensione a dire il Suo nome. Perché non ne sentiamo la
mancanza. Ma se è così, allora uno si domanda: se degli atei hanno
famiglie così belle, che cosa aggiunge, qual è il di-più del cristianesimo?
Per questo, se noi non capiamo che cosa è questo di-più, se noi, strada
facendo nella vita, non cogliamo la differenza tra il fatto che tutto vada
bene e l’urgenza di Cristo, prima o poi ci disinteresseremo della fede.
E siccome abbiamo difficoltà a cogliere questo, poi quando uno ha
una urgenza, quando uno ha una domanda, quando uno ha un desiderio,
non sa che cosa fare: «Dopo trent’anni di movimento, venti di
matrimonio e due figlie adolescenti, sono con le spalle al muro.
Non sono felice. Ho tutto, ma non sono felice. Ho una moglie che mi
vuole bene, due figlie che a scuola vanno bene, un lavoro ben retribuito
anche in questi momenti di crisi, ma sono scontento, cioè non sono
contento di me stesso. Dico di essere con le spalle al muro perché la
domanda di essere felice è proprio grande, da crearmi disagio, da
farmi venire il mal di testa. Riprenderò ad andare dallo psicologo per
farmi aiutare, ma certo non risolverò il problema, ci sono già passato.
Vedo che sposto il problema della mia insoddisfazione incolpando una
volta il lavoro, una volta gli affetti. Credo proprio di essere con le
spalle al muro, non posso più mentirmi. Ho cinquantaquattro anni.
Tu ci hai detto che è nei momenti di difficoltà che si vede a chi uno è
attaccato, quanto è importante Cristo e quanto lo sono le proprie idee».
Il fatto che noi sperimentiamo questa tensione, questa insoddisfazione,
ci fa costantemente bisognosi di Cristo. Guardate che la grande
tentazione del potere è quella di farci credere soddisfatti. La tentazione
del Grande Inquisitore di Dostoevskij è questa, tanto è vero che Gesù
appare come uno che viene a disturbare. Ma noi non vogliamo disturbi,
noi vogliamo che ci lascino in pace! Vi chiedo: questo lasciarci in pace è
la felicità, è la pienezza, è il compimento della vita? Qui ciascuno deve
guardare in faccia questa domanda, devefarne esperienza, perché sono
cose che non si capiscono spiegandole. Continuate a farmi delle
domande cui dovete rispondere voi, come mi scrive uno: «Davanti
alla domanda: “Ma io cosa mi aspetto da Cristo?”, che cosa vuol dire
questo “tutto” di cui parli?». È quel che mi devi dire tu, non
4
chiederlo a me! Perché questa è la verifica della fede. Oppure un altro:
«Cosa vuol dire esattamente aspettarsi tutto dal fatto di Cristo? Che
cosa vuol dire nel quotidiano vivere del fascino per Cristo?».
È ciò che occorre scoprire dall’interno della propria esperienza.
Risposte… Ci sono troppe risposte, ma non ci sono esperienze che
rispondano alle domande; non è che se io rispondo a parole, soddisfo
la vostra insoddisfazione, perché non è una spiegazione che soddisfa,
è un’esperienza! Rendiamoci conto che il fatto di ridestarci la domanda
è l’unica possibilità della verifica della fede, e che è lì, lì, davanti alle
sfide del vivere che io posso vedere la differenza: che cosa introduce
Cristo e qual è il di-più del cristianesimo. Altrimenti il di-più del
cristianesimo per noi è una frase dipinta sul muro che abbiamo sentito
tante volte, ma di cui non sappiamo che esperienza rappresenti; e
questo dice fino a che punto non basta ripetere certe frasi come cosa
ovvia, come presupposto ovvio, perché è proprio avendo fatto così,
come tanti Paesi dell’Europa dimostrano, che abbiamo perso per
strada la fede. O noi ci rendiamo conto di questo, oppure il primo
amore è già sparito dall’orizzonte. Per questo la domanda di Cristo
non è altro che questa: «Ma Io, quando ritornerò, troverò qualcuno a
cui manco, qualcuno per cui la vita sia l’attesa di Me?».
A me ha molto colpito quando il venerdì sera, agli Esercizi, hai fatto la domanda:
«Ma del fascino per il cristianesimo cosa rimane?». Ho avuto un dialogo con un
collega, un nuovo consulente che conosco anche poco, che ha qualche anno
più di me; eravamo a pranzo, due sposati e due non sposati, o meglio, due con
figli e due senza figli. A un certo momento, si parlava di bambini e matrimonio,
e questo dice: «In realtà io vorrei sposarmi, ma poi senti tutte quelle storie per
cui uno ha dei figli, e dopo le cose vanno male, e finisce che dormono in una
macchina perché non hanno più soldi». Un altro giustamente ha risposto:
«Guarda, sposato o non sposato è uguale, se ti devono togliere qualcosa…».
E io dico: «Ma, scusa, al di là delle questioni pratiche, il fatto che tu possa essere
sposato, cioè che tu possa essere con una persona tutta la vita, è una cosa
desiderabile o no?». «Certo che è desiderabile, però io mi rendo conto che una
frase come quella che si dice durante il matrimonio (“Prometto di esserti fedele
sempre”) non la posso dire, se io sono serio con me stesso non la posso dire».
«Giusto, però è desiderabile o no?» «Desiderabile è desiderabile». E allora
gli ho detto: «Scusa, allora più che soffermarsi sul fatto che non ce la fai,
potrebbe essere interessante capire da chi ce la fa dove pesca questa forza».
Non sapevo se lui fosse di Chiesa, quindi andavo un po’ cauto perché mi
interessava evidentemente l’argomento, però non volevo forzare dicendo cose
che magari uno non capiva. Ho detto: «Guarda, dalla mia esperienza quello
che ho visto io è che nel matrimonio cristiano c’è proprio una forza in più che
viene dal Sacramento». E lui mi ha detto: «Però io questo percorso di fede
non l’ho fatto. Questo percorso capisco che è una cosa soggettiva che io
dovrei fare, però io non l’ho fatto». Io gli ho detto: «Guarda, non è tanto una
questione soggettiva nel senso che ci devi pensare su, è una questione
personale senza dubbio, però è una cosa che uno riconosce, è una cosa che
uno vede e allora desidera fare. Per me è stato così». Poi il discorso è andato
avanti. Io mi sono reso conto, parlando con lui e poi ripensandoci, che è vero
che uno a prescindere desidera voler bene alla moglie e ai figli, senza dubbio,
però quel che io ho visto nel matrimonio cristiano è proprio lo sguardo che tu
descrivevi di Zaccheo e Gesù: come deve essersi sentito guardato quando è
stato chiamato? Io ho fatto l’esperienza del perdono all’interno della famiglia
e questa cosa non ci può essere se uno è da solo, non c’è questa possibilità
di guardare l’altra persona a prescindere dagli errori. Dopo quel dialogo mi
sono detto: tutto viene da qui, viene proprio da questo sguardo capace di
accogliere la persona com’è. Conosco due amici che aspettano una
bambina che ha delle malformazioni, che forse sono collegate a qualche
sindrome eccetera, che dicono: «Questa bambina noi la vogliamo»; c’è la
classica possibilità di fare l’amniocentesi, ma io ho visto lo sguardo di
questa mamma che diceva: «Io questi esami non li voglio fare, non mi
interessano, io voglio vedere in faccia questa bambina». Questa cosa non può
stare se non con qualcuno che ti ha guardato così e di cui tu porti dentro la
memoria. Poi, magari, durante il giorno hai altri mille pensieri, ma questa
cosa ti segna e tiene in piedi il matrimonio, tiene in piedi la vita. Quindi il
5
fascino del cristianesimo qui c’è; se non ci fosse, obiettivamente queste
circostanze non potrebbero stare in piedi.
Grazie.
Io parto da una cosa che hai detto tu agli Esercizi, cioè che l’alternativa è chiara: o riconoscere il
fatto oppure non riconoscerlo lasciando prevalere le nostre misure. Parto da questo e da quel che
hai spiegato dopo sulla sequela, cioè che don Giussani dice che la sequela è all’esperienza della
persona e non alla persona. Perché andando a Roma dal Papa mi è capitata questa cosa: sono
andata senza grandi pregiudizi, ma senza grandi aspettative, molto tranquilla anche sulla figura
del Papa, ma senza aspettarmi chissà che. In realtà, quando lui ha iniziato a parlare e mentre
parlava, io ho scoperto di essere “incollata”. È finito il discorso e io non avevo perso una parola.
Mai mi era capitato, tanto che l’unica cosa che ho potuto scrivere, anche a chi mi ha chiesto come
era andata, era questo: «Non ho perso una parola». Dopo, domandandomi che cosa era successo,
mi sono accorta che quando uno testimonia un fatto che è così vero per lui, come il Papa ci ha
raccontato con la sua modalità espressiva, il fatto va al di là della persona, è talmente vero che
ridesta in me tutta l’esperienza che ho fatto io, permettendomi di rileggere tante cose. Per esempio,
tanti discorsi che ho fatto con amici rispetto al movimento, alla guida del movimento, in cui mi
accorgevo di difendere sempre te, difendere un certo tipo di cosa…
Difendere il territorio.
Invece ho scoperto di difendere me! Cioè di difendere la mia esperienza e la mia fede. Quindi anche
quando il Papa diceva: «Accade Cristo», è questo che accade, accade questa esperienza per me.
Bello! Questo ci introduce già a quel che diremo della sequela: ciò che colpisce è che quando uno ci
testimonia un’esperienza, è questo che ci incolla. È questo che don Giussani ci invita a fare per non
perdere tutta la bellezza di quello che accade, cercando di non ridurre la sequela a una delle
riduzioni che abbiamo elencato agli Esercizi. La vera sequela, quella che ci colpisce, che ci trascina,
è partecipare all’esperienza di un altro.
Anche io sono rimasta molto colpita dalle domande con cui tu hai aperto gli Esercizi della
Fraternità: «Quando il Figlio dell’uomo tornerà troverà la fede in me?», oppure quando, leggendo
la lettera dicevi – e questa è la domanda che mi aveva più inquietato – : «Del fascino per Cristo
cosa rimane?». E proprio quella sera, proprio la sera degli Esercizi della Fraternità, mentre
andavo a letto ho capito che del fascino di Cristo rimani tu, Julián, tu che me lo ridai, tu che mi fai
queste domande che io non mi farei più. Così tu che continui a parlarmi, a correggermi, sei la
misericordia che ricrea in me la fede. Forse dico una cosa eterodossa, però l’ho pensato molto in
questi mesi: se don Giussani mi avesse dato e detto tutto quel che mi ha dato e detto, ma non mi
avesse dato te, mi avrebbe imbrogliato, perché io questo fascino non lo avrei più. E questa è la
seconda osservazione che volevo fare: è una presenza che permette di sentire come una promessa e
non come una condanna queste domande, perché se no io queste domande non me le faccio perché
le sento come una condanna; e la vita diventa una serie di conseguenze tratte da una presenza che
è stata e non c’è più, cioè il primo amore diventa un presupposto ovvio. Questo mi ha fatto
impressione in una serie di fatti, l’ultimo dei quali una correzione che tu mi hai fatto ieri, che è
stato il fatto culminante per me di tutto questo periodo, giudicando un disagio che ho vissuto tutti
questi mesi (che ha avuto, in particolare, come epicentro la mia responsabilità in Gioventù
Studentesca), ritrovandomi addosso un risentimento, una delusione che mi sembra la traiettoria
inevitabile di un impeto generoso perché, come tu dicevi alcuni anni fa al Gruppo adulto: «La
generosità prima o poi passa la fattura», e io la fattura la passo presto! Dopo quest’ultima grande
correzione di ieri, io mi sono accorta d’improvviso che era tanto tempo che parlavo di Cristo, ma
che non parlavo più a Cristo. E questo per me segna la differenza tra la fede come presupposto
ovvio e il riconoscimento di una Presenza. Tant’è che non vedevo l’ora che arrivasse la sera per
fare l’ora di silenzio, cosa che non mi accadeva da non so più quanti mesi, non perché non facessi
6
l’ora di silenzio, ma perché l’ora di silenzio era leggere cose su Cristo, leggere un discorso che mi
tornava, ma non più parlare a Cristo. Ed è qui che per me muore il fascino.
Questo introduce il tema della prossima Scuola di comunità sul fascino del cristianesimo come
avvenimento. Perché – approfittiamo di questo intervento per introdurci alla questione – io posso
parlare di Cristo senza sentire l’urgenza di andare a trovarLo. Si capisce? Mi diceva di recente una
persona una cosa simile a quella che raccontavi adesso tu, a proposito di un incontro in cui erano
successe un po’ di cose: «Di tutto quell’incontro mi è rimasto quel momento in cui ho visto una
persona vivere di Cristo, e da quel momento non ho potuto evitare che mi venisse tutta una
nostalgia del silenzio». Adesso me lo hai ricordato. Cioè: il cristianesimo rimane come avvenimento
e non come parola, e non come discorso, e non come istruzioni per l’uso. È come quando a uno non
basta sapere della persona amata, ma vuole andare a trovarla. E questo vuol dire che il fascino è per
Cristo, non per tutto il resto; il fascino è per Cristo. E anche se tutto andasse bene, uno sa comunque
rispondere che cosa è il di-più della vita. Non occorre che succeda un cataclisma, o qualche cosa di
triste; no, può non succedere niente di particolare, ma nella quotidianità si ridesta tutto il desiderio
di Lui, tutta l’esasperata tensione a cercarLo. E questo è un’altra cosa: è una cosa della stessa
natura, nella sua semplicità, dell’inizio del cristianesimo. Gesù non aveva detto a Giovanni e
Andrea dopo il loro primo incontro (non è riportato questo nel racconto del vangelo): «Venite a
trovarMi di nuovo domani». Non c’erano le istruzioni per l’uso, ma essi non hanno potuto resistere
ad andare a trovarlo, ad andare a cercarLo il giorno dopo, e il giorno dopo ancora. Non per un
moralismo, ma per il fascino di Cristo.
Io ho una domanda molto basilare, molto semplice, alla quale forse hai già anche iniziato a
rispondere, ma te la ripropongo così come mi è venuta rispetto al venerdì sera, che io ho percepito
proprio come un incalzare di domande sempre più intense, un crescendo, a partire da quella
iniziale: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»; e poi: «Del fascino
per Cristo cosa rimane?», su, su: «Noi crediamo ancora che Cristo possa riempire la vita?», fino a
quella domanda che è stata più volte evocata, quella dell’Apocalisse: «“Sei costante e hai molto
sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo
amore di prima”. Il nostro primo amore dov’è?». Questo insistere su queste domande ha avuto su
di me l’effetto di mettermi in discussione rispetto proprio a quel che mi sono resa conto di vivere
come un presupposto ovvio, come una cosa scontata: la mia fede. E questo non soltanto quella sera
agli Esercizi; questo disorientamento e il vacillare di una certezza che pensavo di avere mi ha
accompagnato nelle settimane a seguire. Però questo mettere in discussione ciò che mi sembrava
scontato in queste settimane è risuonato in me, mi accorgo, proprio come un rimprovero, per usare
la parola che è citata nell’Apocalisse, come se mettesse in rilievo una mia infedeltà, un mio essere
appagata, soddisfatta di quello che ho, e di non arrivare al punto. Ma io mi domando: è proprio qui
che ci volevi portare? Perché mi tornano poco i conti rispetto al percorso fatto in questi anni in cui,
sempre, ti ho visto invece metterci in guardia dal misurarci sulle nostre prestazioni. Mentre questo
mettermi in discussione a me ha fatto un po’ questo effetto, come a dire: non ci sono quando
pensavo di esserci.
È bellissima questa domanda, perché ci aiuta a cogliere la differenza. Da noi tante volte queste
domande sono sentite come un rimprovero, come un misurare le nostre prestazioni, che può avere
un aspetto vero, ma non è quel che mi interessa ora. Perché io, preparando gli Esercizi e
scegliendone il titolo, avevo presente tutto ciò che avevamo attraversato quest’anno, in cui non c’è
stato risparmiato niente, e ciascuno sa bene la performance che ha fatto e le figure che abbiamo
fatto. Per questo, quel che dici era già palese prima di cominciare la partita. Qui la questione è,
invece, se noi siamo più scoraggiati o più entusiasti della nostra fede. Non è la nostra performance
quel che cerco di evidenziare, ma se qui, in tutto quel che non ci è stato risparmiato, noi abbiamo
colto la Sua presenza. Se essere stati spogliati di tutto, se sentire dire di tutto contro di noi, ci può
separare dall’amore di Cristo. Questa domanda vuol far venire a galla che niente, neanche tutto quel
che avevamo attraversato, avrebbe potuto strapparci di dosso questa evidenza. Ma questo non
7
possiamo raggiungerlo – come tante volte pensiamo – a prescindere da quanto accade, ma soltanto
attraversando quel che accade. Non è che san Paolo non abbia dovuto affrontare enormi difficoltà,
ma queste lo hanno portato a una certezza: «Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo?». Cioè, la
domanda non è per un esame sulla nostra prestazione, ma sul nostro sorprenderci afferrati da Cristo.
Il test non era su di noi, era su Cristo! Perché è lì, in quel momento, che Cristo mostra la Sua
diversità, che rende palese ai nostri occhi chi è Lui. Che cosa resiste? Non resiste la nostra
prestazione (lo sappiamo bene), non resiste la nostra energia, resiste Lui, la Sua presenza. Resiste
Colui che ci ha afferrati. Resiste il riconoscimento della Sua presenza, che non è lo sforzo
volontaristico di un riconoscimento, ma è lo stupefacente stupore dell’inizio moltiplicato
all’infinito. Infatti pensiamo: «Va bene che Lui mi voglia bene all’inizio»; il problema è che quando
conosce tutto di me, quando sa tutti i miei errori, ancora Lui abbia pietà di me, ancora Lui abbia
cura di me, ancora Lui si mostri così decisivo per la mia vita, tanto che niente e nessuno può
separarmi da Lui, questo mi fa dire: ma chi è Cristo? Lo scopo delle domande del venerdì sera è far
venir fuori tutta la novità di Cristo, perché è questo che ci consente di essere grati, che ci consente
di vivere la fede come riconoscimento di una presenza così eccezionale da rimanere sbalorditi.
Allora ciò che resiste non siamo noi, ciò che resiste è Lui, ciò che dura è Lui. La verità è quel che
dura nel tempo. Ciò che resiste è Lui. Lo abbiamo visto, il Dio di Israele può portare il suo popolo
all’esilio per mostrare che Lui è un Dio diverso; per tutti gli altri popoli, appena cade l’impero è
finito il loro dio, ma Lui può permettere l’esilio per mostrare che rimane per sempre. E questo è ciò
che ci dà tutta la certezza per fare la strada, è un punto di certezza incrollabile che si fonda non sulle
nostre prestazioni, ma su di Lui. Questo è il cammino della fede che noi vogliamo continuare a
percorrere. La strada – come vedete – non sono i commenti sul testo, ma vedere, accompagnati dal
testo, tutta l’esperienza che si svolge davanti ai nostri occhi nella realtà. Sta qui tutta la diversità. Da
questo punto di vista, è impressionante potere addirittura fare questo percorso con la compagnia di
quel che papa Francesco ci ha detto quando siamo andati a Roma. Nella sua semplicità disarmante
ci ha mostrato questo, ci ha testimoniato questo: davanti alla crisi dell’umano (che non si può
ridurre a sociologia, perché non basta una organizzazione per risolverla) occorre Gesù, Gesù! E
quindi la fede è un incontro con Gesù, è un riconoscimento della Sua presenza; e questo vuol dire
che la comunicazione della fede si può fare soltanto con la testimonianza, cioè col mettere davanti
agli altri un’esperienza. È proprio questo che ci consente di seguire il Papa in tutte le modalità con
cui ci sorprende: che esperienza ha di Cristo da aver bisogno della preghiera, da aver bisogno di
lasciarsi guardare da Gesù! Perché se uno come dice papa Francesco può vivere la vita lasciandosi
guidare da Gesù, è perché Gesù non è un personaggio o un discorso del passato, ma è
contemporaneo e sta agendo nella vita. È Lui che attraverso le circostanze più banali ci chiama a
rispondere, ci ridesta. Per questo se noi abbiamo presente, anche nel lavoro sugli Esercizi, tutto
quanto il Papa ci ha testimoniato nella sua semplicità, possiamo trovare un aiuto prezioso per poter
toccare con mano che cosa vuol dire la fede come un’esperienza vissuta, non semplicemente –
riprendo proprio l’immagine usata dal Papa – come riflessioni teologiche da fare a tavolino
prendendo il tè. Altroché! Per questo occorre uscire verso la realtà e verificarlo lì, non fare la
chioccia.
La prossima Scuola di comunità si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 21.30. Riprenderemo la Prima
lezione degli Esercizi della Fraternità, come già abbiamo introdotto oggi.
Il Movimento per la vita, come sapete, ha lanciato l’iniziativa “Uno di Noi”, a cui hanno aderito
tute le associazioni cattoliche. Si tratta di una raccolta firme a livello europeo per richiedere la
cessazione del finanziamento ad attività che favoriscono l’aborto e ricerche che presuppongono la
distruzione di embrioni umani. Troverete il modulo per la raccolta firme anche allegato a Tracce di
giugno. Raccomandiamo la raccolta firme nei propri ambiti di studio o lavoro, tra i vostri familiari,
amici e conoscenti, nelle parrocchie dove non fosse ancora stata fatta e, possibilmente, in
collaborazione con altre associazioni.
8
È provvidenziale per ciascuno di noi sostenere questa iniziativa mentre stiamo leggendo come Libro
del mese Il potere dei senza potere, perché questo libro non pone questioni datate soltanto al
periodo dell’impero sovietico, ma ripropone con chiarezza che il vero potere che ogni uomo ha, che
l’io ha, è l’amore alla realtà e alla verità delle cose. È questo che permette di non essere omologati
alla mentalità dominante, che forse oggi è ancora più pervasiva di quella imposta dal regime
sovietico. L’esperienza cristiana rende più acuto questo amore alla realtà e alla verità delle cose e
l’affermazione di questo vale per la coscienza di sé e per la crescita della propria umanità più di
qualsiasi risultato nell’immediato.
Veni Sancte Spiritus
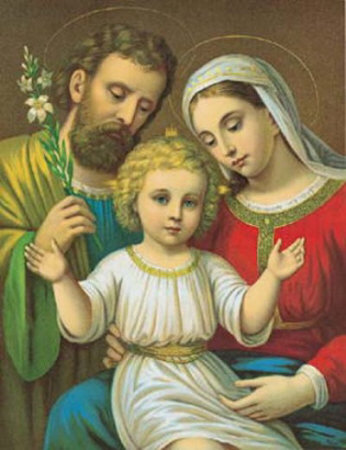
 Un cristiano non usa un “linguaggio socialmente educato”, incline all’ipocrisia, ma si fa portavoce della verità del Vangelo con la stessa trasparenza dei bambini. È l’insegnamento che Papa Francesco ha offerto nell’omelia della Messa celebrata questa mattina a Casa Santa Marta. Con il Pontefice hanno concelebrato il patriarca dei cattolici armeni, Nerses Bedros XIX Tarmouni, mons. Fernando Vianney, vescovo di Kandy nello Sri Lanka, e mons. Jean Luis Brugues della Biblioteca Apostolica Vaticana, accompagnato da un gruppo di collaboratori della struttura. Presenti anche la presidente e il direttore generale della Rai, Anna Maria Tarantola e Luigi Gubitosi, con i loro familiari.
Un cristiano non usa un “linguaggio socialmente educato”, incline all’ipocrisia, ma si fa portavoce della verità del Vangelo con la stessa trasparenza dei bambini. È l’insegnamento che Papa Francesco ha offerto nell’omelia della Messa celebrata questa mattina a Casa Santa Marta. Con il Pontefice hanno concelebrato il patriarca dei cattolici armeni, Nerses Bedros XIX Tarmouni, mons. Fernando Vianney, vescovo di Kandy nello Sri Lanka, e mons. Jean Luis Brugues della Biblioteca Apostolica Vaticana, accompagnato da un gruppo di collaboratori della struttura. Presenti anche la presidente e il direttore generale della Rai, Anna Maria Tarantola e Luigi Gubitosi, con i loro familiari.








